Chiudi
Chiudi
Vauchez André
Sommario
Introduzione [di A. Vauchez] 9
Parte prima
I FONDATORI E LA LORO MEMORIA ►
I. San Domenico e le origini dei Frati Predicatori 17
II. San Francesco d’Assisi, o il Vangelo nel quotidiano 31
III. Santa Chiara d’Assisi: una vita per la povertà 45
IV. La stigmatizzazione di san Francesco d’Assisi. Significato e portata storica 54
V. Le stimmate di san Francesco e i loro detrattori negli ultimi secoli del Medioevo 65
VI. Jacopo da Voragine e i santi del XIII secolo nella «Legenda aurea» 92
Parte seconda
I MENDICANTI NELLA SOCIETÀ COMUNALE ►
VII. Una campagna di pacificazione intorno al 1233. L’azione politica degli Ordini Mendicanti secondo la riforma degli statuti comunali e gli accordi di pace 119
VIII. Genesi e funzionamento dell’inquisizione medievale 162
IX. Un inquisitore domenicano: san Pietro martire (1200/ 1252 ca.) 171
X. Il processo di canonizzazione di san Nicola da Tolentino quale fonte storica (Marche 1325) 177
XI. Il culto dei «nuovi» santi in Umbria nei secoli XIII e XIV 186
XII. Il comune di Siena, gli Ordini Mendicanti e il culto dei santi. Storia e insegnamenti di una crisi (novembre 1328-aprile 1329) 194
XIII. Penitenti laici e terziari in Italia nel XIII e XIV secolo 206
XIV. I cambiamenti del sistema assistenziale negli ultimi secoli del Medioevo 221
Parte terza
CONTRASTI INTERNI E MODELLI SPIRITUALI ►
XV. L’ordine francescano nei secoli XIII e XIV: tra ideale e realtà 233
XVI. Il posto della povertà nei documenti agiografici all’epoca degli Spirituali 244
XVII. Le canonizzazioni di san Tommaso e di san Bonaventura: perché due secoli di scarto? 257
XVIII. Frati Minori, eremitismo e santità laica: Le «Vite» dei santi Maio (m. 1270 ca.) e Marzio (m. 1301) di Gualdo Tadino 274
XIX. Alcune riflessioni sul movimento dell’Osservanza in Italia nel secolo XV 306
Conclusione 311
Nota bibliografica 317
Introduzione [di A. Vauchez] 9
Parte prima
I FONDATORI E LA LORO MEMORIA ►
I. San Domenico e le origini dei Frati Predicatori 17
II. San Francesco d’Assisi, o il Vangelo nel quotidiano 31
III. Santa Chiara d’Assisi: una vita per la povertà 45
IV. La stigmatizzazione di san Francesco d’Assisi. Significato e portata storica 54
V. Le stimmate di san Francesco e i loro detrattori negli ultimi secoli del Medioevo 65
VI. Jacopo da Voragine e i santi del XIII secolo nella «Legenda aurea» 92
Parte seconda
I MENDICANTI NELLA SOCIETÀ COMUNALE ►
VII. Una campagna di pacificazione intorno al 1233. L’azione politica degli Ordini Mendicanti secondo la riforma degli statuti comunali e gli accordi di pace 119
VIII. Genesi e funzionamento dell’inquisizione medievale 162
IX. Un inquisitore domenicano: san Pietro martire (1200/ 1252 ca.) 171
X. Il processo di canonizzazione di san Nicola da Tolentino quale fonte storica (Marche 1325) 177
XI. Il culto dei «nuovi» santi in Umbria nei secoli XIII e XIV 186
XII. Il comune di Siena, gli Ordini Mendicanti e il culto dei santi. Storia e insegnamenti di una crisi (novembre 1328-aprile 1329) 194
XIII. Penitenti laici e terziari in Italia nel XIII e XIV secolo 206
XIV. I cambiamenti del sistema assistenziale negli ultimi secoli del Medioevo 221
Parte terza
CONTRASTI INTERNI E MODELLI SPIRITUALI ►
XV. L’ordine francescano nei secoli XIII e XIV: tra ideale e realtà 233
XVI. Il posto della povertà nei documenti agiografici all’epoca degli Spirituali 244
XVII. Le canonizzazioni di san Tommaso e di san Bonaventura: perché due secoli di scarto? 257
XVIII. Frati Minori, eremitismo e santità laica: Le «Vite» dei santi Maio (m. 1270 ca.) e Marzio (m. 1301) di Gualdo Tadino 274
XIX. Alcune riflessioni sul movimento dell’Osservanza in Italia nel secolo XV 306
Conclusione 311
Nota bibliografica 317
Avvertenza 320



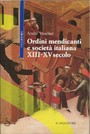

(Dalla Introduzione di André Vauchez)